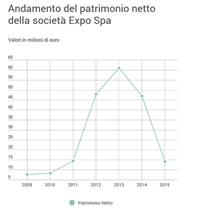4 novembre 2015
Della visita all’Expo ricordo con piacere l’atmosfera festosa e la fluida organizzazione. Condiviso, penso, perché in quest’occasione ognuno ha potuto sentirsi ben accolto in tutto il mondo, per di più all’insegna del nutrimento, universale nelle pur vertiginose differenze del mondo reale. I quotidiani gratuiti (fondamentali nell’alfabetizzarci) scrivono di un’indagine della Camera di Commercio e del Comune, in cui nove intervistati su dieci si dicono entusiasti e in molti casi hanno visitato la città, i musei e naturalmente il quadrilatero, facilitati dalla semplicità di spostamento con i mezzi pubblici, dalla facile reperibilità dei luoghi, dallo stile e dall’eleganza milanesi.
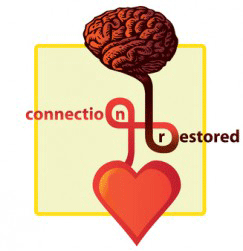 Segno bifronte di successo, molti padiglioni avevano un naso lungo, anzi lunghissimo, di persone civilmente in attesa di entrare. In quanti abbiamo visitato i padiglioni meno celebrati, per facilità di accesso? Merito involontario ma non secondario di una manifestazione universale. Perciò ho notato le due (forse più, ma due ne ho notate) eccezioni dei padiglioni di USA e Germania dotati di rampe di accesso ampie e agevoli, efficace invito a entrare. Naturalmente conta l’ampiezza dei padiglioni, ma altri mi sono parsi non meno grandi e, tuttavia, con ingressi centellinanti masse apparentemente inesauribili di visitatori. Come se i loro progettisti avessero ignorato di avere a che fare col mondo. Se così è, sono figli del nostro tempo.
Segno bifronte di successo, molti padiglioni avevano un naso lungo, anzi lunghissimo, di persone civilmente in attesa di entrare. In quanti abbiamo visitato i padiglioni meno celebrati, per facilità di accesso? Merito involontario ma non secondario di una manifestazione universale. Perciò ho notato le due (forse più, ma due ne ho notate) eccezioni dei padiglioni di USA e Germania dotati di rampe di accesso ampie e agevoli, efficace invito a entrare. Naturalmente conta l’ampiezza dei padiglioni, ma altri mi sono parsi non meno grandi e, tuttavia, con ingressi centellinanti masse apparentemente inesauribili di visitatori. Come se i loro progettisti avessero ignorato di avere a che fare col mondo. Se così è, sono figli del nostro tempo.
Con i quantitative easing di USA, UE e ora Cina (soldi pubblici a interessi irrisori alle imprese) «per i grandi gruppi i tassi di interesse storicamente bassi sono una vera ancora di salvezza: la loro priorità è di consolidare il sistema produttivo buttandosi in fusioni e acquisizioni. Prendono il controllo delle attività materiali e immateriali più promettenti; razionalizzano l’apparato produttivo; fanno guerra di posizione ponendosi alla testa di ecosistemi di cui controllano tecnologia, normative e mercati, come Apple e Google, per captare il massimo del valore. Priorità è dominare il mercato, non aumentare l’investimento produttivo».
Lo spreco di talento e tempo delle persone, giovani in particolare, e di soldi pubblici spiega la crisi globale: sempre più soldi, meno lavoro e ricchezza. E sempre peggio: «Si profila un'”automazione barbara”, la disintegrazione già in atto dei lavori tipici della classe media. Investitori e categorie in grado di trarre diretto vantaggio dagli aumenti di produttività e dai recuperi dei margini di profitto, si appropriano della rendita tecnologica». [Laurent Faibis e Olivier Passet, «De la mondialisation sauvage à l’automatisation barbare?», Le Monde, 14/10/2015, p. 7]. Anche con tecnologie che paghiamo a nostro apparente beneficio, come conferma il provvisoriamente ultimo scandalo Volkswagen (e Bosch).
Da sempre le risorse abbondanti e poco costose sono sprecate, come oggi lavoro denaro ambiente. Il costo differito non c’è fin che salgono i profitti dei ponti di comando che, senza responsabilità né controlli, agiscono solo nel breve periodo, o brevissimo perché non si sa mai. Recitano a soggetto, improvvisano questa trasformazione radicale universale delle cui conseguenze non si curano.
Ritroviamo l’improvvisazione originaria della globalizzazione nel sedicesimo secolo, documentata da Timothy Brook: «Le interazioni si fecero più intense e più fitte, anche se gli effetti che ne conseguivano erano difficili da prevedere o da comprendere. […] Fu un periodo, questo, in cui si dovette modificare il proprio modo di agire e di pensare al fine di conciliare le differenze culturali, di sventare minacce impreviste e di cogliere opportunità altrettanto inattese. Un periodo che si prestava non alla realizzazione di grandi progetti, ma all’improvvisazione. L’età delle scoperte era ormai conclusa, mentre quella dell’imperialismo doveva ancora arrivare» [Il cappello di Vermeer. Il Seicento e la nascita del mondo globalizzato, Einaudi 2015, p. 24].
Dovremmo aver imparato che neppure gli affari si fanno senza grandi progetti, allora nazionalisti e imperiali, a cominciare dall’invenzione degli Stati con la pace di Vestfalia nel 1648. Anche oggi gli affari rovinano, senza progetti politici che tengano insieme il tutto. Il business è un sistema aperto, che cerca il successo anche con mezzi illeciti, ma l’economia – nazionale e globale – è un sistema chiuso, in cui le reazioni a decisioni importanti sono complesse e di lungo termine, e l’aggressione significa guerra. «Molti faticano a cogliere la differenza di complessità tra una grandissima azienda, anche la più grande del mondo, e un’economia nazionale. L’economia americana occupa 120 milioni di persone, circa 200 volte la General Motors, il primo datore di lavoro degli Stati Uniti. […] Un matematico ci direbbe che il numero di interazioni potenziali tra un vasto gruppo di persone è proporzionale al quadrato del loro numero. […] Ma allora come si può gestire un’entità così complessa? Un’economia nazionale va gestita sulla base di principi generali, e non di strategie specifiche. […] I grandi leader aziendali hanno una conoscenza dettagliata e una comprensione intuitiva del proprio settore che nessuno – per quanto intelligente – può avere di un sistema complesso come un’economia nazionale.
Eppure, l’idea che il metodo migliore per gestire una economia sia quasi sempre fissare un quadro di riferimento corretto e poi lasciarla andare per conto suo non ha senso per i dirigenti e gli imprenditori, il cui approccio intuitivo è, come ha detto Ross Perot, “aprire il cofano e mettersi a lavorare sul motore”». [Paul Krugman, Un paese non è un’azienda, Garzanti 2015, pp. 31-4]. «La prossima volta che sentirete dei manager esprimere delle opinioni sull’economia, domandatevi: “Si sono presi il tempo che occorre per studiare a fondo questo argomento? Hanno letto quello che scrivono gli esperti?”. Se non l’hanno fatto, non tenete conto del successo che hanno avuto negli affari. Ignorateli, perché probabilmente non sanno nemmeno di cosa stanno parlando» [p. 56]. Infatti.
Pensati o improvvisati, condivisi o imposti i grandi progetti comunque arrivano. Già le guerre di Ucraina e Siria si sono saldate intorno a noi e se «gli imperi passano, le mentalità imperiali restano. Mai la parola “impero” è stata così utilizzata dalla fine della guerra fredda nel 1991. “Imperi economici”, “digitali”, “mediatici” e “nostalgia degli imperi” sono le formule che segnano il passo della nostra epoca in cui lo Stato-nazione è rimesso in questione». Ma, «dopo gli imperi e le nazioni come modelli, è apparso un terzo riferimento del tutto nuovo: l’Unione europea. Nazioni che hanno liberamente scelto di associarsi a dispetto delle incertezze del mondo» [Gaïdz Minassian, «Quand l’histoire globale favorise la revanche des empires», Le Monde, 17/10/2015, p. 18].
Questa è anche la testimonianza di Expo, universale addirittura, e viene dalla pancia oltre che da testa e cuore. Senza forse essersela cercata, Milano ha una bella responsabilità.
Giuseppe Gario