9 settembre 2015
Se dovessi definire grossolanamente la costante delle elezioni comunali milanesi, pur nelle ovvie differenze di sistemi elettorali, platea degli elettori e soggetti politici, direi in sintesi: “I progressisti vincono quando moderati, conservatori e reazionari si dividono e i conservatori vincono quando i progressisti e i radicali si dividono”.
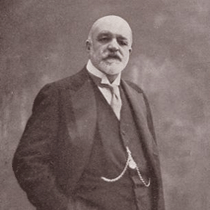 Un esempio chiarissimo di questa costante si ha alle elezioni del 1911. Dimessosi il sindaco Ponti rappresentante il liberalismo moderato, per evitare il commissariamento viene eletto sindaco l’avvocato e assessore anziano Bassano Gabba, oggi ricordato solo per la splendida casa liberty che fece costruire a Bergamo, ma al tempo studioso di certa importanza, moderato e anticlericale. La maggioranza, per quanto divisa, aveva infatti bisogno di concludere i lavori del piano regolatore tanto più che la situazione economica non era più quella del 1906.
Un esempio chiarissimo di questa costante si ha alle elezioni del 1911. Dimessosi il sindaco Ponti rappresentante il liberalismo moderato, per evitare il commissariamento viene eletto sindaco l’avvocato e assessore anziano Bassano Gabba, oggi ricordato solo per la splendida casa liberty che fece costruire a Bergamo, ma al tempo studioso di certa importanza, moderato e anticlericale. La maggioranza, per quanto divisa, aveva infatti bisogno di concludere i lavori del piano regolatore tanto più che la situazione economica non era più quella del 1906.
La parte più conservatrice del consiglio aveva come obiettivo la revanche ovvero eliminare quello che era ancora un vulnus: la tassa di famiglia, così prendendo a pretesto l’agitazione degli esercenti per il rincaro delle tasse sulle aree e sulle insegne si espresse contro la giunta. Come disse Turati: “Si è manifestato una screpolatura che attesta i profondi dissidi interni, non che la tendenza ad andare a colpire la tassa di famiglia e in una parola, tutto l’indirizzo democratico del sistema tributario dell’Amministrazione milanese. E codesto solo è il vero protagonista della discussione di stasera, e questa sola la ragione dell’accanita battaglia combattuta fuori di qua […] combattere la tassa di famiglia significa far pagare agli altri le spese che avete fatto voi. Vuol dire tassa sui fabbricati rinforzata con le addizionali, conseguente reversibilità degli affitti, rincrudimento delle pigioni“.
Turati vedeva la convivenza di due schieramenti all’interno della maggioranza: quella moderata del sindaco che avrebbe voluto continuare la politica della precedente, e quella reazionaria che invece avrebbe voluto riprendere la tradizione di fine secolo delle giunte “proprietarie”. Il voto divise maggioranza e opposizione e la tassa sugli esercenti passò con l’appoggio determinante dei socialisti, non raro esempio di maggioranza trasversale, provocando le dimissioni alcuni assessori.
Di fronte a questa sconfitta, i conservatori decisero di passare all’attacco Nel gennaio 1910 stante che il bilancio comunale mostrava uno scoperto di 22 milioni, il capo dei reazionari e futuro sindaco Emanuele Greppi (nessuna parentela con il sindaco della liberazione) chiese lo scioglimento del consiglio: “L’era dei debiti è aperta in via assoluta, indefinita. Io non ho paura dei debiti, ma ho paura della mancanza di denaro per pagare gli interessi dei debiti. Sento che mi è diminuita la fiducia nella giunta: e questo sentimento è legittimo. Se poi ci opponiamo alla Giunta è per il desidero che quando ci si trova in una poesia di questo genere il dovere è uno solo: si interpella il corpo elettorale“.
Ma la richieste elezioni venne respinta aprendo un’ulteriore frattura nello schieramento moderato. L’ex sindaco Ponti fece infatti sapere che di fronte al trattamento riservato a “antichi e benemeriti collaboratori”, egli non avrebbe fatto che “prendere piena libertà d’azione”, che cioè non si sarebbe ricandidato, mentre si dimettevano gli assessori a lui vicini.
Lo stesso “Corriere della Sera“, che appoggiava l’ex-sindaco industriale, stigmatizzò la linea oltranzista dei liberali milanesi, “l’entusiasmo degli elementi più moderati milanesi per l’alleanza con i cattolici. Nel loro orrore per le imprese municipalizzate v’è anche un po’ dello stesso sentimento dal quale nasce l’orrore per la tassa di famiglia: sentimento di classe, diciamolo apertamente, che ripugna i tributi diretti e preferisca quelli indiretti“. Ed era l’opinione di Luigi Albertini!
Nonostante tutto, alle elezioni convocate per il 22 gennaio 1911, i liberali non potevano andare divisi, pena davvero la vittoria dei socialisti e – orrore! – Majno o Caldara sullo scranno di Palazzo Marino. Si giunse così a un compromesso e nelle liste liberali, vennero così inseriti alcuni nomi della Giunta Ponti ma non più l’ex sindaco. Compromesso che non trovarono socialisti e i radicali che si presentarono, divisi, il che rendeva quasi certa la vittoria della destra.
Gli elettori furono pochi, neppure il 50% degli aventi diritto. Vinsero i costituzionali con 17.000 voti, l’opposizione (il sistema era maggioritario) fu dei socialisti (che avevano fermamente rifiutato l’alleanza con i radicali) con 10.000 voti, i radicali (con i repubblicani e alcune Leghe operaie) si fermano a 9.500 e non entrano in consiglio. Il primo eletto non fu un moderato, ma il medico, primario all’Ospedale civile Edoardo Bonardi, eletto tra i socialisti ma votato anche dai radicali con 18.469 voti (fosse stato candidato di un’alleanza sarebbe stato sindaco). Vi fu chi chiese in ragione di questo di ripetere le elezioni. I costituzionali erano 64, 16 i socialisti. Ragione principale della vittoria di Greppi, oltre che la posizione intransigente dei socialisti, fu il compatto schierarsi con la conservazione dei cattolici, come scrisse l’Osservatore Romano il 24 gennaio: “A Milano come sempre, come ovunque, i cattolici sono apparsi per quello che sono di fatto, un contingente sommamente prezioso e indispensabile del quale ormai non possono fare a meno i partiti costituzionalisti liberali che non vogliono andare travolti e rimanere sommersi nella piena sempre più rigonfia e minacciosa dei partiti popolari.” Più chiari di così!
Il programma di Greppi fu impostato alla modestia notarile e un po’ gretta della destra lombarda: “Norma della nostra condotta sarà il paragone costante e accurato fra i vantaggi di una soluzione che importi una spesa, e i danni che qualsiasi spesa talmente arreca, sia che sottoponga una disponibilità del bilancio ad altra possibile destinazione sia che aumenti il debito, sia che renda necessaria una nuova imposta, nelle condizioni nostre attuali la libertà della nostra azione subisce ancora restrizioni maggiori. Molti lavori sono impegnati, i quali debbono necessariamente essere condotti a termine […] Maggior speranze nutriamo nella diffusione del giusto sentimento della impellente e imprescindibile necessità dell’economia e del risparmio in tutti gli ordini dell’amministrazione, dai capi fino ai più modesti funzionari […] Più sicura, più decisa sarà poi la nostra azione nell’opporci a nuove spese. Noi resisteremo alle sirene che volessero tentarci. Dobbiamo imporci la massima che, appunto perché è difficile tornare indietro su spese già consentite, è vero, è necessario non accogliere titoli nuovi di spese“.
Discorso politico? Piuttosto un discorso ragionieristico. Del resto, Greppi era tutto tranne che una fine mente politica. Appartenente a una famiglia nobile di antica tradizione meneghina era stato eletto per la prima volta in consiglio nel 1885; più volte assessore e deputato, rappresentava quel mondo notabilare e conservatore milanese, assai vicino ai milieux cattolici che, prima del patto Gentiloni, non avevano rappresentanza propria. Fu anche presidente dell’ANCI e nel dopoguerra divenne fascista.
Persino un esponente della sua stessa maggioranza, e non certo un progressista, Giovanni Beltrami, disse che il comportamento di Greppi gli ricordava più “un buon padre di famiglia, il quale facesse con molta diligenza e molta lucidità i propri conti di casa“. Per Beltrami, se la città versava in quel momento in una “depressione finanziaria” ciò non doveva costituire un ripiegamento, di quella che era la “città più operosa d’Italia”: “Un partito può credesi in diritto di assistere e di tenere il potere, alla sola condizione di avere delle idealità da ridurre in atto, ed io non posso pensare che le idealità nostre debbano ridursi a redigere un bilancio sul scorta degli uffici di ragioneria […] Non li amiamo dunque nessuno debito, ma o preferisco ancora i debiti, e magari molti debiti, quando, bene usa possano giovare al maggiore sviluppo e al maggior benessere della città, piuttosto che le ricchezze della vita porta che arrischino di intristire, di mortificare la vita, e di compromettere l’avvenire.”.
Le misure di risparmio, (Greppi definì la sua politica di bilancio “invernale”) neanche a dirlo, colpirono l’istruzione, con l’accorpamento di aule e l’eliminazione delle scuole meno numerose, diminuirono il numero di vie fognarie e tagliarono le spese sulla nettezza urbana (e la città divenne più sporca, soprattutto nei quartieri popolari). Un disastro che colpì nell’agosto gli impianti della centrale idroelettrica valtellinese, dimostrò poi l’imperizia e l’incuria della giunta Greppi verso le imprese municipalizzate. La giunta Greppi si presentava, pur nella modestia del suo discorso, come giunta d’opposizione alle scelte del governo centrale e del governo Giolitti.
Specularmente i radicali acquisivano, un ruolo fondamentale: quello di rappresentanti della politica del governo a Milano, tanto che il “Secolo” divenne il principale organo governativo nell’area cittadina. Fino alla guerra di Libia però filogiolittiani erano anche i socialisti, così che la battaglia contro la reazionaria giunta Greppi, sembrò far ritornare i bei giorni dell’unione popolare, delle battaglia contro il “clericame”.
Nel 1913, rientrato il bilancio, la Giunta cominciò a pensare a nuovi progetti: il primo fu quello di allargare lo spazio dell’Università. Alle cascine Doppie, oltre Porta Venezia, si prevedeva l’allargamento del Politecnico e dell’Accademia scientifico letteraria. I socialisti si opposero: Bonardi lamentava che “venticinque mila bambini sono privi di assistenza per mancanza di asili e di giardini d’infanzia, un terzo della popolazione formata da famiglie di 4-5-8 persone vive in una o due stanze, la tubercolosi miete non meno di 2.000 persone all’anno“. Per Claudio Treves “un’università politecnica darà benefici alla classe borghese, che da questi istituti trarrà il vantaggio immediato del rifiorire delle sue industrie. La classe borghese ha molto desiderio di scienza, ma poca volontà di tirare fuori i quattrini, e tutto questo entusiasmo per l’alta cultura da parte della borghesia è a spese dello Stato, del comune e della provincia“.
La Milano politica degli anni Dieci davvero in nulla poteva ricordare quella di vent’anni prima. All’epoca v’erano due raggruppamenti, liberali e democratici, le cui distinzioni erano assai spesso sfumate, tanto che i candidati dell’una lista passavano agevolmente nell’altra, e non per trasformismo, quanto per la convinzione, che avevano visto confermato nell’immediato ventennio postunitario, dell’inutilità della politica, del suo carattere tutto sommato accessorio, un’appendice di parole e di discussioni per giovani idealisti o per attempati perdigiorno, mentre gli uomini seri, e soprattutto i lombardi, concreti, dovevano trovare i mezzi per fare al più presto, con maggior profitto e minor dispendio, le “cose”.
Modernità sia, pensavano i moderati lombardi, purché non venisse scalzato il regime proprietario e il suo equilibrio di ordine e di valori, di ascendenza corporativa, in cui il mercante, il contadino, il manovale, il muratore andavano rispettati in quanto “lavoratori” ma finché non deflettevano dal posto assegnatogli dalla rappresentazione sociale della borghesia proprietaria. Una borghesia proprietaria che per questa ragione non riusciva a rappresentare i ceti imprenditoriali i quali, benché provenienti da quei gruppi sociali erano nondimeno favorevoli a quella “modernità” che prevedeva in primis industrializzazione e democrazia. Per questo, almeno nei primi decenni unitari, gli imprenditori più dinamici, di prima o seconda generazione, li troviamo nelle liste dei radicali.
Una borghesia in maggioranza contraria alle spinte riformatrici che venivano “da Roma”, e soprattutto all’allargamento dell’elettorato, fin dai tempi dall’odiato Crispi – odiato non perché illiberale ma perché troppo centralizzatore e interventista sulle cose milanesi, per il resto il suo pugno di ferro contro le organizzazioni operaie e socialiste appariva persino troppo tiepido ai loro occhi.
I liberali giolittiani non erano molti a Milano. Ponti, che involontariamente fece una politica giolittiana, fu duramente attaccato dalla destra liberale, ma lui stesso non riuscì a capacitarsi della propria posizione, perché il suo programma avrebbe richiesto una maggioranza diversa (quella radicale e socialista) da quella che concretamente sosteneva la giunta. Ciò è da spiegarsi non con il carattere eretico di Ponti, quanto con l’assenza di un ceto medio liberaldemocratico a Milano. L’estremizzazione bipolare della politica locale caratterizzò quindi gli anni immediatamente precedenti la guerra: da un lato la giunta dall’altra i socialisti. Proposte che ai nostri occhi possono apparire moderate di un Caldara e di un Turati, erano guardate con orrore dai ceti medi e dalla giunta. I più pensavano che la radicalizzazione dovesse favorire il Greppi.
Invece alle elezioni politiche del 1913, (le prime a suffragio allargato, ma anche della nuova platea, raddoppiata, votò poco più del 40%), risulteranno eletti tre socialisti (Turati, Treves, Maffioli) due radicali e un liberale. Dopo il risultato Greppi si dimette, il Corriere della Sera lamenta “i danni che i legami tropo stretti con i cattolici hanno provocato ai liberali“, si va a nuove elezioni comunali. Ma questa è un’altra storia
Walter Marossi
